Oggi, un giorno qualunque di questo caldo fine agosto, sono andato a salutare per l’ultima volta zia Augusta, che, dopo aver raggiunto alla chetichella gli ottantasette anni, se n’è andata da questo mondo.
Soprannominata in famiglia “La Zia di Monza”, era la moglie di mio zio Emilio, fratello minore di mio padre, considerato, anche lui, il piccolo di famiglia per la minore età rispetto agli altri fratelli. Si erano sposati pochi anni dopo che lo zio era tornato dalla guerra, da un lungo periodo di prigionia in India dove l’avevano portato gli Inglesi, una sorta di vacanza, diceva lui. Era stato fatto prigioniero in Africa, insieme a molti altri, mentre sciupavano la gioventù costretti a combattere la gloriosa, celebrata guerra. Come raccontava spesso, lui era stato parecchio fortunato, altri suoi compagni avevano dovuto donare la giovane vita alla patria. Diceva di aver salvato la pelle perché, meccanico, se ne stava non proprio di fronte al nemico. Gli piaceva raccontare gli episodi in cui era stato favorito dalla sorte.
Da sposati, erano andati a vivere a Monza, dove la zia abitava con i genitori e due fratelli, entrambi minori di lei.
Famiglia veneta come tante altre, emigrata poco prima della guerra, in cerca di lavoro. Lei era una sarta molto abile, apprezzata, lavorava in casa confezionando abiti per una clientela medioborghese, abbastanza selezionata. Lui era il “tutto fare” di una piccola ma qualificata autofficina in cui aveva iniziato a lavorare quando era molto giovane.
La semplice cerimonia si è svolta in un paesotto alle falde delle colline di Montevecchia, che si ergono ben visibili verso nord.
Un tempo piccolo paese immerso nel verde, oggi grande, ordinato, coerente ai nuovi canoni socio-edilizi di questi e tanti altri posti. Pieno di nuove strade, soffocato da nuove case, nuove villette singole, a schiera, con molti meno campi e prati verdi, tanti dei quali non sembrano nemmeno più coltivati.
Da bambino venivo da queste parti con mia madre.
Andavamo in un’antica frazione di Missaglia, chiamata Contra, poco più di qualche cortile, addossato a due ombrose ville patrizie. Di questo luogo, era originaria mia nonna paterna, che non ho mai conosciuto, morta poco prima che nascessi. Dal paese, il breve viaggio si faceva con la corriera. Si veniva a trovare questi parenti poche volte all’anno in occasione di feste o per particolari ricorrenze, sposalizi, lutti.
Oggi non ne so più nulla e non riuscirei neanche a riconoscere dove vivevano. Ricordo solo che la località veniva anche chiamata “Cà rossa”, ma non mi sembra proprio che le case dei contadini di allora avessero questo colore, le ricordo più dimesse. Forse era rossa la casa padronale nel giardino della villa che occupava parte della valle, che dava il nome al posto.
L’unico congiunto che ricordo era un signore che mia madre chiamava Ezio o Enzo.
Arrivava abbastanza spesso a casa nostra nell’intervallo del mezzogiorno, operaio nel salumificio “Milano” di Besana, portava sempre qualcosa del salumificio, si fermava a pranzo. Era alto, capelli ricci, nerissimi, folti baffi, occhi scuri, accesi, modi semplici ma sicuri. Aveva una voce garbata, discuteva con mia madre di tanti argomenti che io non ascoltavo, qualche volta allungava una carezza chiedendomi se ero un bravo bambino. Anni dopo, mia madre lo ha assistito per una grave malattia quando era degente nel piccolo ospedale di Besana, poi non so che ne sia stato di lui, forse quella malattia lo ha portato alla tomba.
Quando arrivo, incontro una nipote che mi ragguaglia su come la zia ci ha lasciati.
Consumata dall’età dice lei, o forse solo dalla solitudine, penso io. Andava di notte a suonare i campanelli in giro per le vie, chiamava senza motivo conoscenti e amici, faceva discorsi solo suoi, senza più nessun argomento sensato.
- Era andata giù di testa, tuttavia aveva, da tempo, pensato a tutto, comprato un loculo al cimitero per lo zio Emilio e per sé, lasciato scritto le sue volontà, come quella di essere cremata, preparate le foto da esporre sulla tomba. Dopo essere stata ricoverata per pochi mesi a Milano in una Casa per vecchi, si è spenta, come recita il referto, per insufficienza respiratoria, o forse cardiaca.
Che importanza può avere ormai sapere questi particolari, mi rimprovero, penso di non aver mai fatto nulla per questa zia.
Dalla morte dello zio, non sono mai andato a trovarla, l’ho incontrata solo in rarissime occasioni, per matrimoni, lutti. Mi aveva chiesto, con insistenza:
- Perché non mi vieni mai a trovare ? Mi farebbe molto piacere!
Ho sempre promesso, non l’ho mai fatto.
Mentre ascolto la nipote, ricordo l’ultima volta che l’ho vista, in occasione dei funerali di mio fratello Luca, poco più di un anno prima. Al cimitero, al termine della cerimonia, mi aveva accompagnato a vedere dove riposava lo zio, che aveva fatto spostare dal cimitero di Monza dove l’avevamo accompagnato molti anni prima. Mi disse che aveva comprato due posti nell’ossario posto molto vicino alle tombe della mia famiglia. Davanti a quei piccoli quadrati di marmo che riempiono l’ampia parete, mi aveva indicato la minuscola foto dello zio, con un maglione bianco dolcevita, troppo giovane, avevo pensato. Poi, accarezzando il marmo del posto a fianco, non occupato, con molta serenità mi aveva sussurrato:
- Qui ci entrerò io, è questo il mio futuro, - aggiungendo, mentre mi abbracciava con gli occhi colmi di lacrime, la voce tremante - ci verrò molto, molto presto, sai!
Mentre aspetto fuori dalla chiesa, arrivano altri parenti che non vedo da sempre.
Mi trattengo per salutare, constatare che il tempo non ha fatto sconti a nessuno.
- Sono come una mela, bella fuori, un po’ marcia dentro.
Non riesco, non so cosa rispondere, gli stringo forte il braccio, un’altra cugina è appoggiata al braccio del marito che la sorregge, la guida venendomi incontro.
Ha gli occhi sbarrati, muove la testa con scatti improvvisi come in cerca di qualcosa. Chiede chi sono, quando glielo dicono si commuove, dice che non mi avrebbe mai riconosciuto, tanto sono cambiato, mi dicono che è diventata cieca da oramai molti anni, una malattia virale.
Incontri che mi scuotono, mi causano sensazioni contrastanti.
Ricordi sopiti che affiorano, immagini colorate, grigie, la testa che rimugina, che prende atto del lavoro inarrestabile del tempo, che costringe a guardare, senza filtri. Entro in chiesa dalla navata centrale, mi stupisco nel vedere la molta gente già presente. Mi viene in mente quello che, da piccolo, sentivo dire quando si commentavano i funerali:
- No, non c’era molta gente, solo i parenti stretti, è stato un bel funerale.
Chissà come la povera zia vede oggi il suo funerale?
La gente è sparsa, sgranandosi occupa entrambe le file di panche allineate, fin quasi a ridosso dell’altare. Dalle prime panche, alcune anziane signore stanno recitando il rosario.
Cerco volti conosciuti di parenti, amici, sul momento non riconosco nessuno.
In attesa della cerimonia, la zia è già davanti all’altare, chiusa in una semplice bara di legno chiaro su cui è posata una corona di fiori. A metà chiesa, noto le spalle larghe di una figura seduta da sola nel mezzo di una panca, porta una camicia azzurra di tessuto grezzo, con le maniche appena arrotolate, ha tanti capelli bianchi, lunghi quasi come i miei, ai tempi in cui giocavo “alla rivoluzione”. Mi avvicino incuriosito, scopro che il personaggio è mio cugino Silvano. Mi guarda con aria per nulla stupita, vi leggo una bonaria ramanzina, con calma mi dice:
- Tu non ti fai mai vedere, solo qualche rara volta compari e solo in queste belle occasioni - accennando con la testa alla bara davanti all’altare.
Contemporaneamente, mi allunga la mano, dura, callosa, la stringo forte, molto volentieri.
- Come stai ? - gli chiedo a mezza voce, avvicinandomi per non disturbare chi sta pregando.
Lui mi guarda con occhi interrogativi e, prevenendomi, mi dice orgoglioso:
- Oramai ho ottant’anni, gli stessi di tuo fratello Luca, che se n’è già andato, però lavoro ancora. Del resto è quello che ho fatto per tutta la vita, io non sono mai andato né al mare né in montagna, ho sempre solo lavorato, mi piace farlo ancora - poi conclude un po’ sconsolato - Ma ora, non ci sento quasi più.
L’avevo sospettato.
Mi siedo accanto a lui e mi trovo sintonizzato con la monotona litania del rosario che stanno recitando, chissà da quanto tempo non ho occasione di sentirla.
Penso che è la preghiera collettiva che si recitava in chiesa nei quaranta giorni della Quaresima e tutte le sere a maggio, mese dedicato alla Madonna. Da ragazzo, amavo quelle sere, non certo per il rosario ma per i giochi che si facevano prima e dopo la funzione. Nonostante gli anni trascorsi, mi accorgo che la cadenza della preghiera, l’enunciazione dei misteri mi appartengono ancora.
Con il sommesso vocio di sottofondo, in attesa dell’inizio della funzione, guardo la zia e la mia mente prende a correre via.
Cerco di raffigurarmela giovane: figura minuta, capelli lisci, mai lunghi, i grandi occhi scuri, i denti sporgenti, effetto dell’aver succhiato a lungo il pollice per alleviare la pena di crescere come l’unica figlia femmina in una famiglia con due baldi figli maschi. Famiglia piccoloborghese, di città, come tante altre di cui allora mi colpivano i modi di fare, l’esternazione dei sentimenti, che comparivano e si materializzavano, i comportamenti diversi da quelli delle famiglie contadine. Mi sembra di sentire ancora la sua cadenza lenta, il ritmo del suo parlare solo in italiano. Non l’ho mai sentita dire nulla in dialetto, che però ha sempre capito benissimo.
Mi scuote lo scampanellio che annuncia l’entrata del prete sull’altare per l’inizio della cerimonia.
Le navate della chiesa sono invase da un profondo suono d’organo, che vedo sistemato nell’abside di fianco all’altare: è suonato da un signore non più giovanissimo, che, nell’intonare il motivo d’introduzione alla funzione, esibisce anche una bella voce baritonale. Il parroco è accompagnato da tre disinvolte giovani ragazze che fungono da chierichetti, che prendono posizione sull’altare ai lati dell’officiante. Non frequentando da tempo le funzioni, sono sorpreso per questa riforma dei secolari canoni ecclesiastici.
Si arriva all’omelia, che spesso assume il carattere di “predica”.
Il parroco, alto, magro, di carnagione scura, dai modi lenti, ovattati, si avvicina al leggio, appoggia le mani di fianco al grande libro aperto davanti a lui, alza gli occhi, per prendere cognizione della gente presente, con calma, percorre l’intera chiesa.
Con voce flebile, al limite dell’udibile, cita uno dei due mie leggendari “Ernesti”, lo scrittore, in uno dei suoi lavori più belli e famosi.
- E allora, non chiedere mai per chi suoni la campana, essa suona per te.
Sono stupito, mi concentro per sentire, cercare di capire, ma riesco a seguirlo a malapena nelle prime frasi del discorso.
Il cugino Silvano, per attirare la mia attenzione, mi afferra per un braccio, mi giro a guardarlo, con aria di protesta rassegnata dice:
- Io non capisco niente, non sento niente di quello che sta dicendo e tu?
Avvicinandomi il più possibile all’orecchio gli rispondo:
- Sì, anch’io faccio fatica, parla molto piano.
Ottengo solo:
- Cos’hai detto? - agito in cerchio il dito a indicare “dopo”.
Silvano capisce tutto, fa un mezzo sorriso, riprende a guardare il prete con aria beata come se sentisse, capisse tutto.
Seguendo a stento l’omelia, riesco a sapere che la zia si era inserita nella realtà del paese, ma non aveva mai rinunciato al suo modo d’essere discreto, distaccato.
Finisco per distrarmi e per pensare a come debba aver realmente vissuto in tutti questi anni, da quando, dopo la morte dello zio, si era trasferita in quel paese tanto diverso da una città, anche se piccola, come Monza.
Ci avevo già pensato altre volte, non riuscivo a spiegarmi questa scelta, tenendo conto del suo carattere o perlomeno di quello che io ero riuscito a capire di lei. Credo che la decisione fosse stata dettata da esigenze di carattere economico. La zia aveva sempre lavorato in proprio, era possibile che avesse una pensione bassa.
Alla fine il Parroco annuncia che lei aveva da qualche tempo espressamente chiesto di essere cremata, il prete non nasconde, anzi, fa trasparire dal tono la sua contrarietà.
Finito il sermone, riprendono i riti della messa, accompagnati dal suono solenne dell’organo, dalla cristallina voce del provetto baritono, fino ad arrivare alla benedizione della bara, che chiude la cerimonia. I quattro addetti, con modi sicuri, calmi, solenni sollevano la zia, a passi cadenzati si avviano verso l’uscita, dove l’attende una grande auto nera che la porterà alla cremazione.
In silenzio la seguiamo tutti.
Sul sagrato assistiamo all’ultima benedizione e ci accingiamo a porgere le condoglianze di rito ai suoi parenti più stretti; suo fratello Gigi ha vicino la figlia, le nipoti.
Non trovo traccia della moglie, vagamente mi ricordo che in famiglia era famosa perché fumava, non chiedo nulla in merito. Gigi ha un aspetto giovanile, ben curato, gli occhi, il sorriso mi ricordano quelli della famiglia, in particolare di suo fratello maggiore, mi metto in fila, aspetto il mio turno.
Mi avvicino, gli stringo la mano, gli dico chi sono.
Lui sbarra gli occhi, gira qua e là la testa quasi in cerca di aiuto.
- Non ti conosco, non ricordo, non ti ho mai visto.
Insisto.
- Sono il nipote dello zio Emilio - e, senza dargli tregua, - mi vedevi da piccolo, quando passavo qualche tempo ospite a Monza dalla zia.
Niente, non funziona, Gigi sembra non ricordare nulla, quasi per giustificarsi mi dice:
- Ho anch’io oramai più di ottant’anni, non mi ricordo più di tante cose, ma non ti conosco, non ti ho mai visto.
Interviene la figlia, che lo sorregge con il braccio:
- Papà, sono i parenti di Besana, i famigliari dell’Emilio, il marito di tua sorella.
A questo punto ha come un sussulto, sbatte gli occhi, prende la mia mano tra le sue, con fare trionfante, mi dice:
- Ah, sì! Sì! Mi ricordo, mi ricordo di voi, dei parenti della campagna!
Quando il feretro parte per la sua destinazione, saluto tutti, con la solita promessa di farmi vedere presto.
L’asfalto appena rifatto mi sembra nerissimo, la stretta carreggiata si snoda nella campagna, che pare più verde del solito. Ho gli occhi fissi di quando mi estranio, non ho nessuna fretta, guido piano, provo a rallentare il tempo sperando di riuscire a riacchiappare qualche parte recondita di me, colgo un sottile senso di colpa.
L’incontro con la morte, non quella raccontata, quella reale, quella che ti costringe a guardarla negli occhi, libera arcani pensieri.
La vista di una vita finita spezza la catena che ho usato per legarli, tenerli lontani, come cani sciolti ora mi si avventano contro. Confondo i due piani: chi è morto, me stesso, quello che guardo, con quello che sento. Il dolore profondo, o anche solo il dispiacere che mi provoca la vista di una morte, mi fa percepire la certezza della fine della vita, che di solito tengo a freno. Certezza che non ha possibilità di appello, certezza che vale per chi se n’è andato, ma anche per me.
La fine della vita evidenzia l’enigma del dove si andrà, in quale spazio, in quale tempo, dove andrà la zia, dove andrò io. Mi ripeto i consueti interrogativi, seguiti dalle più pensabili o inverosimili risposte, emergono le più profonde e radicate ansie e paure. Queste angosce, questi timori la zia li aveva prima, ora non li ha più, mentre in me, col passare del tempo, sembrano aumentare sempre di più.
Per sfuggire a questo ruminare, volgo lo sguardo al passato, come un convoglio sulla retta del tempo; affiorano i ricordi, le sequenze, le tappe degli eventi, le immagini, gli incroci di esistenza condivisi con gli zii di Monza.
Si è già detto che gli zii lavoravano e abitavano a Monza.
Attorno alla metà degli anni Cinquanta vivevano in un appartamentino in affitto, due locali e una cucina. Una casa di ringhiera che si affacciava su un ampio cortile delimitato da un alto muro. Allineati c’erano alberi dall’alto fusto, tra un albero e l’altro comode panche, a strisce di legno verde scuro, su cui sostavano a chiacchierare massaie e nonni. Di bambini che giocavano non me ne ricordo, forse era proibito o proprio non c’erano bambini. Nella parete a sinistra del cortile, quasi a ridosso del muro, c’era una “vedovella” di ghisa di colore verde scuro, la fontana comune: poche case avevano acqua all’interno. Nel punto più lontano dalle abitazioni un’alta, fitta siepe di laurotto nascondeva l’entrata ai gabinetti di tutti. L’entrata della casa degli zii si affacciava su una piccola via, traversa di una più ampia che portava al vialone di fronte alla Villa Reale.
Quando lo zio Emilio era tornato dalla guerra, aveva vissuto nella casa paterna, la stessa in cui viveva la famiglia del fratello maggiore, mio padre.
Alla morte prematura della nonna era stato accudito da mia madre e da mia sorella Rosella, che aveva solo qualche anno meno di lui. Per questi motivi, ma anche per fare un giro in campagna, nel verde, quasi tutte le domeniche pomeriggio gli zii venivano al paese. Non avendo figli, con un buon lavoro, stabile, potevano permettersi l’auto, una Topolino, un lusso, perché a quei tempi in paese solo i patrizi che abitavano nelle grandi ville e qualche commerciante si potevano concedere l’automobile.
Gli zii di Monza avevano però un problema, che era ritenuto tale da tutta la famiglia: non avevano figli.
Dell’argomento mia madre parlava spesso, solo anni dopo ebbi modo, se non di capire fino in fondo, almeno di intuire i risvolti, le implicazioni emotive che quella situazione aveva avuto sulla loro vita. Non chiesi mai e dunque non seppi mai i reali motivi, gli intenti, le motivazioni di mia madre quando mi affidava a loro, che cominciarono a portarmi a Monza, ospite per qualche giorno. In quelle occasioni ero sommerso di attenzioni, cosa che non succedeva in famiglia, dove le attenzioni nei miei riguardi si limitavano a quando combinavo guai; in quei casi, le premure erano di segno opposto.
È una delle prime volte che sono ospite da loro, la zia mi porta in giro per la città, mi presenta ad alcune amiche, a qualche signora a cui confeziona i vestiti, mi riveste, da capo a piedi.
Con lei raggiante, i pacchetti in mano, ritorniamo a casa e sulla scala incontriamo la madre della zia, che, avendo saputo della mia presenza, è venuta a cercarci. Mi dà un bacio, mi accarezza la testa, mi dice frasi di circostanza, che io non sento mai, mi vien da pensare che forse anche lei sogna un nipotino.
Una volta in casa, le due donne si mettono a scartare i pacchetti, commentando ogni pezzo comprato.
Poi, con entusiasmo crescente e modi cordiali, me li fanno indossare: una maglietta azzurro chiaro con maniche corte, un paio di calzoni blu scuri di leggero velluto a coste che loro definiscono corti, ma mi arrivano al ginocchio, se non oltre. Questa cosa mi preoccupa molto, perché da noi si portano calzoni corti sul serio, calzoni di quel tipo li portano i figli dei ricchi e sono, tra i tanti altri, un motivo di distinzione. Un altro problema è rappresentato dai sandali, dai calzini: i sandali sono blu scuro, tutti chiusi con due piccoli fori quasi sulla punta, le calze sono bianche, lunghe fin quasi alle ginocchia, una cosa disgustosa. Infine, ciliegina sulla torta, un cappello tondo semisferico, rigido, con una profonda falda, sormontata da un fregio di stoffa dorata. Mai vista una cosa simile.
Entrambe, zia e madre, molto soddisfatte, mi ammirano.
Con un sorriso gioioso mi spingono a guardarmi allo specchio della sala, quello in cui si rimirano le signore a cui la zia confeziona i vestiti. Sono rassegnato, eseguo in modo meccanico e non trovo nessun argomento per oppormi che loro possano accettare, dentro ho il fuoco, mi sembra di sudare.
Quello che mi guarda dallo specchio sono io, non mi sembra vero, non posso crederci! Nel frattempo loro mi girano intorno, aggiustando i vestiti qua e là.
- Sei molto bello! Ti piaci? Come ti senti? Farai un figurone!
Gli amici del paese non mi reputano un eroe, io mi assolvo pensando che non è nella mia natura esserlo, tuttavia in questa occasione mi sembra di esserlo ancora meno.
Forse per quello, sento che il bollore che ho dentro si propaga. Verso sera da un po’ accaldato divento rosso sulle gote, al punto che la zia se ne accorge: il termometro dice febbre a più di trentotto gradi.
È l’origine di un mezzo dramma.
La zia, spaventata, mi fa sdraiare sul divano, mi copre, mi fa bere qualcosa di amaro, avvisa mezzo mondo delle mie condizioni, tranne i miei genitori al paese, noi non abbiamo il telefono.
Preoccupato, lo zio torna in anticipo dal lavoro; io sto meglio, forse è stato solo lo spavento, la febbre, misurata ogni cinque minuti, si sta abbassando, per prudenza però mi lasciano a letto, mi servono una cena leggera.
Qualche giorno dopo, nel pomeriggio, non sapendo più che cosa farmi fare la zia mi porta ai giardini della Ville Reale.
Sono belli, enormi, ci sono tanti giochi che io non ho mai visto, tanti bambini vocianti vanno su e giù dallo stesso attrezzo in continuazione, sembrano divertirsi. Non sono abituato a quel modo di giocare, in paese non abbiamo né giardini né attrezzi, solo cortili, prati, campi, ruscelli, alberi. Lei mi spinge a giocare, a correre, a scendere dagli scivoli, lo faccio con poca voglia, senza entusiasmo, provo a parlare con qualche bambino, a giocare con loro, solo per accontentare lei, che ci tiene tanto e, seduta sulla panchina, mi esorta.
Questi brevi soggiorni furono pochi, l’esperimento fallì del tutto la volta che mi dovettero portare a casa di sera tardi.
Non so spiegare il motivo che causò questa decisione, rammento molto bene la frustrazione, il senso di colpa, durante il breve viaggio non ci scambiammo quasi nessuna parola. Arrivati a casa, parlottarono con mia madre, che ogni tanto mi lanciava sguardi indagatori. Rimasto solo con la mamma, con il tono che assumeva quando non mi voleva sgridare, mi disse di andare a letto, perché era molto tardi.
Indugiai solo per un attimo, il tempo di guardare quel viso, quelle labbra appena aperte in un tenue sorriso, quegli occhi lucidi. Mi era sembrato di capire che mia madre era felice.
All’inizio degli anni Sessanta, la mia vita s’intrecciò ancora con quella degli zii.
Contro il mio volere, mi avevano iscritto a una scuola serale di Monza e gli zii si erano offerti di ospitarmi a dormire, le lezioni terminavano tardi. Nel frattempo avevano cambiato casa, ora vivevano in un condominio, in fondo a una via che, rasentando il muro di cinta del parco, portava a Villasanta.
Nel breve periodo che durò la nuova esperienza, gli zii furono sempre molto cordiali, disponibili, e mi trattarono con tanto affetto.
Era però diverso da quando mi avevano ospitato da bambino, allora non sentivo più il sentimento affettivo forte, manifestato in vari modi, che pativo, allora c’era più distacco, più dovere; ero uno dei nipoti cresciuti, che stavano ospitando facendo un piacere alla famiglia.
Questa volta l’esperienza durò ancora meno dei mesi dell’anno scolastico, interrotta bruscamente quando abbandonai la scuola, un’esperienza grigia per ambo le parti.
In seguito a quel distacco, non ebbi altri contatti diretti, li incontravo solo di rado al paese, da mia sorella, per le solite liete o tragiche vicende familiari. In quelle occasioni si dimostravano sempre cordiali, la zia s’interessava alle mie vicende, manifestava il suo apprezzamento, come se avesse dimenticato gli episodi del passato.
Con i miei fratelli invece, complice la vicinanza d’età, si frequentavano con assiduità, trascorrendo insieme anche periodi di vacanza.
Fu proprio in una di queste vacanze che, a metà degli anni Settanta, lo zio cominciò ad avere problemi di salute. Erano ospiti su un’isola della laguna di Venezia, da vecchi conoscenti della zia, nata da quelle parti, e lui cominciò a non stare bene. Mio fratello poi mi raccontò che, pur stando parecchio al sole, aveva preso uno strano pallore. Non sembrava nulla di preoccupante, ma, poco dopo, si ammalò gravemente e in pochissimo tempo si capì che non ce l’avrebbe fatta. Tutta la famiglia si strinse intorno agli zii, anch’io mi offrii di aiutare, assistendo, in breve tempo, al suo aggravarsi.
Nelle veglie ci parliamo poco, rispondo solo alle sue richieste, ai suoi bisogni.
Qualche volta mi chiede della famiglia, del lavoro, lo fa però con tanta stanchezza, dandomi l’impressione che è solo per sdebitarsi; soffre, sembra essere già lontano. Nelle lunghe ore notturne, non gli ho mai chiesto nulla del passato, anche se ne ho avuta tanta voglia. Guardo a lungo quello zio che frequento da quando sono nato, mi chiedo se l’ho mai davvero conosciuto. Vorrei sollecitare un dialogo, ma ho timore che ciò possa far insorgere qualche suo interrogativo sul suo reale stato di salute. Con il passare del tempo, poi, si vede con chiarezza il suo distacco, presta attenzione sempre più a fatica, si distrae, insegue suoi reconditi pensieri.
Quando arrivo in ospedale, come sempre ad attendermi c’è la zia, che mi appare molto provata.
Lo zio è immobile, gli occhi chiusi, per via della febbre alta ha un panno bagnato sulla fronte, la bocca è leggermente aperta, il respiro irregolare. Dopo avergli asciugato la fronte, averlo baciato, la zia si avvia lentamente verso l’uscita, l’accompagno con lo sguardo. Arrivata in fondo all’ampio corridoio, come presa da un improvviso pensiero, si gira, sembra voler ritornare sui suoi passi, le corro incontro, mi prende la mano, non me l’aspettavo.
- Stai vicino a tuo zio - prende tempo, cerca le parole - ti ha voluto tanto bene sai, non puoi sapere neanche quanto, non gli resta molto da vivere.
Una verità, ammesso che possa esistere, ha molti modi di rivelarsi; per ognuno di questi, suscita stati emotivi contrastanti, dissimili.
Davanti a quel corpo oramai immobile, quelle parole sono come sberle che mi scuotono, che mi fanno intuire una realtà che non ho mai saputo cogliere, parole che mi feriscono, lasciandomi frastornato. Quasi non mi accorgo che lei si è voltata, se ne sta andando con un passo lento che assorbe la stanchezza. La guardo, sono tentato di chiamarla, rincorrerla, abbracciarla, ma non lo faccio, non ne sono capace.
Torno in corsia, non è cambiato nulla. Del resto, cosa sarebbe potuto cambiare?
Mi siedo a fianco dello zio, osservo il volto, l’ansimare che muove il lenzuolo che gli copre il petto, fatto scarno dalla malattia, ripenso alle parole che lei mi ha appena riassunto, mi chiedo quanto siano profonde. Mi è difficile valutare cosa sento, quali sentimenti mi attraversano, forse sono capace di vivere solo emozioni che si accentuano in determinati momenti.
Per tutti il tempo è breve ma, per lo zio, sta per finire. Torno a pensare agli eventi della vita degli zii.
Si avvicina un infermiere, mi chiede se ho bisogno, rispondo di no, però, curioso, gli domando come mai ci sono tutte quelle bottiglie vuote vicino all’armadio, sotto il lavandino di servizio. L’infermiere mi dice che, giorni prima, lo zio aveva manifestato un grande desiderio di bere l’acqua che in paese chiamano “della fontana”. Lo zio l’aveva chiesta per lenire la grande arsura che la malattia gli procurava, ma forse anche per tornare in qualche modo alla sua infanzia, sentiva che era l’ultima volta che poteva berla.
Con questi pensieri, misuro il lento passare delle ore.
Cambio spesso il panno sulla fronte, che sembra scottare sempre di più. Verso mezzanotte, quando il reparto è immerso nel silenzio dei rumori dei sofferenti che provano a far passare la notte, ritorna l’infermiere, che sta facendo un giro di controllo.
- Come va? - mi chiede avvicinandosi.
- Normale - rispondo - non ho notato nessun cambiamento.
L’infermiere prende il polso del malato, con gli occhi puntati sull’orologio controlla il battito, posa la mano sulla fronte, fa dondolare il capo.
Si gira, mi guarda, aspetta un attimo prima di dirmi:
- Mi spiace dirlo, ma tuo zio è agli sgoccioli, il polso è molto debole, la febbre è altissima, noi non possiamo fare più nulla.
Cosa mi vuole dire?
- Fossi in te lo porterei a casa, almeno là potrà morire in pace, se muore qui in ospedale, poi sarà molto complicato portarlo via.
Sapevo che, prima o poi, sarebbe successo, ma sono scosso, confuso, biascico:
- Quindi secondo lei è meglio portarlo a casa?
- Certo! Se hai bisogno, io sono di là - e si avvia.
Rimasto solo guardo ancora per un po’ quel volto bianco, segnato dalla malattia, quella bocca semiaperta, ascolto il suo sordo affanno, penso che, portandolo via, decido senza più nessuna speranza la sua fine.
Prendo i gettoni del telefono, il biglietto dei numeri che la zia ha lasciato sul comodino, mi avvio verso la postazione telefonica in fondo al corridoio.
L’infermiere è molto gentile, si occupa di tutto. Mi consiglia di non salire sull’ambulanza, non serve, chiede agli addetti di aspettarmi all’uscita. È un viaggio lento, vuoto, il convoglio attraversa la città addormentata, deserta, silenziosa. Gli infermieri lo trasportano nella camera, lo adagiano sul letto, già preparato dalla zia. Li ringrazio, li accompagno fino al pianerottolo, se ne vanno.
La zia ha chiuso la porta della stanza, dalla quale adesso non proviene più nessun rumore, mi dice che, allo zio, adesso ci pensa lei.
Va in cucina, si siede, la raggiungo, mi siedo dall’altro capo del piccolo tavolo. Stiamo così, senza dire nulla, in attesa di niente.
È lei a rompere il silenzio, chiedendomi come va il lavoro.
Sono sorpreso, balbetto qualcosa, lei non sembra nemmeno sentire, tiene lo sguardo fisso, le mani raccolte in grembo. Forse, per rompere quel nulla, dopo poco, mi offre un caffè che accetto, si mette a prepararlo, lo mette sul fornello.
- Ti ricordi quando venivi a dormire da noi e ti lasciavo la caffettiera pronta perché tu partivi presto al mattino? Bevilo! Bevilo con calma, se vuoi in frigo c’è anche del latte.
Non aspetta la risposta, si ferma ancora un attimo, tende la mano verso la mia testa, ma si ferma.
- Vado dallo zio, aspettami qui.
È passato tanto tempo, ore.
In punta di piedi, mi avvicino alla porta, vedo che è solo accostata. Con cautela socchiudo, senza entrare, sbircio. La zia è distesa sul letto accoccolata a fianco del marito, ha gli occhi chiusi, affonda il viso sopra la sua spalla, vicino al volto, ha le braccia piegate sul petto, le ginocchia raccolte contro le sue.
Sembravano entrambi addormentati.
Mi fermo sulla soglia; non posso entrare, sono solo un estraneo.
Ho lo sguardo fisso su quell’immagine, che mi cattura, mi intenerisce al punto che sono preso da una sorta di euforia, un sollievo, un’emozione che include serenità, sollievo, liberazione.
Suggestione che sembra contrastare con quanto sta accadendo in quella stanza, in quel momento.
Nel chiudere la porta, attento a non fare rumore, scorgo un bambolotto ben vestito con le braccia alzate appoggiato sulla poltrona di fronte al letto e in silenzio torno sui miei passi.
 Racconti
Racconti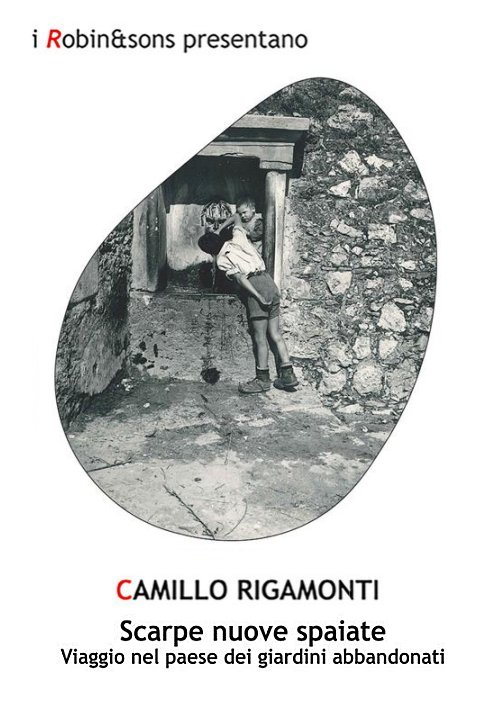 Scarpe nuove spaiate
Scarpe nuove spaiate Quattro sfigati e una Seicento
Quattro sfigati e una Seicento Casa Aragosta
Casa Aragosta Margherite
Margherite