Il patrono del mio paese è S. Clemente, ricorre il ventitré novembre; non sappiamo chi abbia stabilito che, la domenica più vicina a questa data, si organizza l’annuale festa del paese.
È una festa sentita da tutti, in tutte le famiglie, i contadini non hanno tempo e soldi per altri svaghi, se non per le feste religiose. C’è il tempo dell’attesa, vissuta e alimentata dai discorsi, dai preparativi, di certo la parte più bella, emozionante. C’è il coinvolgimento delle persone, dei giovani, che cominciano a organizzare e vivere la festa molto prima del giorno in cui è celebrata. Ci sono i riti religiosi, che iniziano già nelle settimane che precedono l’evento con le veglie di preghiera, che portano in chiesa l’intero paese. Ci sono i discorsi, i racconti in famiglia, all’osteria, che ricordano le feste passate, che commentano i preparativi e fanno progetti in merito.
- Quest’anno - propone una sera a cena mia madre qualche tempo prima della ricorrenza - per la festa del paese potremmo fare i cannelloni ripieni. Sono un piatto che noi non abbiamo mai preparato, mio fratello Luisot dice che sono anche più appetitosi delle lasagne.
La proposta però non riscuote successo, la discussione che ne segue serve a stabilire, in linea di massima, il menù di quell’anno: antipasto di salame nostrano e sottaceti, risotto giallo con frattaglie di pollo, di secondo gallina lessa e coniglio arrosto. Non viene neanche messo in discussione il dolce, perché, da sempre, da queste parti si fa la torta paesana, detta da alcuni torta di pane, o torta di latte, ritenuta in ogni caso da tutti insostituibile.
Nei giorni che precedono l’evento, si manifesta un fervore che si diffonde sempre più con l’avvicinarsi della festa e coinvolge un po’ tutti, anche i più ritrosi, i più distaccati, quelli meno entusiasti di sempre.
Si arriva così al sabato sera, la vigilia della festa, il momento tanto atteso, il più bello, con tutto il paese in agitazione. C’è stata la cerimonia serale nella chiesa, già addobbata a festa nei giorni precedenti dal sagrestano, aiutato da varie pie donne che si sono rese disponibili per l’occasione.
Dopo la cerimonia, noi ragazzi, nonostante la serata fredda e nebbiosa, ci troviamo in piazza, come fossimo ancora in estate.
Giochiamo a nascondino, facciamo baccano, grida, urla, richiami. Le ragazze addette all’organizzazione della pesca stanno sistemando sugli scaffali gli ultimi premi. Giovanotti volonterosi che hanno già innalzato l’albero della cuccagna, con la scusa di voler dare una mano, gironzolano intorno alle sottane, che non disdegnano certe attenzioni.
Nelle osterie, è un pullulare di gente intenta a giocare a carte, a bere, a chiacchierare.
Nelle famiglie si sta preparando il pranzo del giorno dopo, dando la priorità assoluta alla torta paesana. Si vivono momenti di emozioni semplici, che si accumulano in ognuno in modo diverso, ma si sedimentano nel profondo, non se ne andranno mai più via.
Il paese è troppo piccolo, qui non arrivano le giostre come a Besana, non si fanno nemmeno vedere i banchetti ambulanti di dolciumi, caldarroste, zucchero filato, come alla festa di Santa Caterina, anch’essa in quel periodo, ma la gente sembra non sentirne la mancanza.
Tuttavia, si sono organizzati diversi giochi e attrazioni: la pesca di beneficenza, la ruota della fortuna, la corsa dei sacchi, la corsa in coppia con le gambe legate, le pignatte rotte e, come gran finale, l’albero della cuccagna. Non si fanno i fuochi di artificio, da queste parti non si usa, o forse perché sarebbero costati troppo. In Brianza, prima di spendere, ci si pensa per bene.
La pesca di beneficenza richiede un’organizzazione non banale, il gioco è semplice.
Si pesca, da dei grandi vasi di vetro, uno dei tanti biglietti che contiene e su cui è scritto un numero, prima abbinato a un oggetto ben visibile ed esposto sugli scaffali, il premio conquistato. Tutto questo è preparato in un locale che di volta in volta gli organizzatori trovano in qualche cortile del paese. Per un giorno il locale diventava il clou della festa, dove si recano tutti almeno una volta a pescare.
Nello stesso locale è allestita la ruota della fortuna, che consiste in un grande cerchio di legno sulla cui circonferenza sono segnati numeri in progressione, da uno a trenta, delimitati da chiodi.
La ruota è fissata a un grande palo di sostegno con un perno centrale sul quale ruota e sulla cima del quale è fissata una lama flessibile, che s’inserisce tra un chiodo e l’altro e che segna il numero corrispondente. Facendo girare la ruota, il rumore della lamina contro i chiodi prepara all’esito del gioco, perché quando cessa, la lama è ferma tra un chiodo e l’altro, indicando il numero disegnato sulla ruota; è quello del biglietto venduto a chi ha vinto e si prende il premio.
La domenica mattina mia madre mi sveglia presto, anche se la sera della vigilia abbiamo fatto tardi, prima giocando in piazza, gironzolando per il paese, poi in casa a sentire le chiacchiere dei genitori, dei vicini, che raccontano cose dei tempi andati e che a me piace tanto ascoltare.
Mia madre mi esorta a vestirmi per la cerimonia, tra non molto arrivano col treno gli zii della Canonica, invitati per l’occasione, e devo accompagnare lo zio in chiesa per la messa solenne.
Gli zii della Canonica sono molto religiosi, lo zio fa parte del coro, è considerato un discreto baritono.
Di mio padre non si può dire la stessa cosa, lui, quelle volte che va a messa, come tanti altri, la segue dalla sacrestia; - Sempre un piede dentro e uno fuori - lo canzona mia madre senza malanimo.
Non mi oppongo a vestirmi per la festa, anche se in quegli abiti non mi sento a mio agio, costretto, rigido, devo anche stare attento a non sporcarmi, a tenermi in ordine.
Sono andato con mio fratello ad aspettare gli zii alla stazione, poi abbiamo fatto a piedi la strada fino al paese. Dopo i soliti convenevoli di rito, mia madre mi affida allo zio perché lo accompagni in chiesa, dicendo di fare in fretta per prendere posto, perché ci sarà tanta gente. Troviamo posto in una panca a metà chiesa e io rinuncio ad andare davanti, come al solito, con gli altri ragazzi.
Lo zio, appena occupata la panca, sembra assentarsi.
Si è inginocchiato, ha messo le mani sul volto chino. Io lo guardo, giro l’occhio verso le panche dei miei amici, mi vergogno. Lo zio rimane in quell’atteggiamento per un tempo che mi pare eterno, intanto la chiesa si va riempendo. Finalmente si mette a sedere e comincia a guardarsi in giro, è proprio quello che fanno tutti.
La chiesa è tutta addobbata con festoni rosso porpora, altri addobbi d’oro decorano le navate.
Davanti all’altare, attaccato a un filo di ferro che scende dall’altissimo soffitto, è sospeso un grosso pallone, sembra soffice bambagia grigia chiaro.
- È bella la vostra chiesina ! - mi dice lo zio - mi piace sempre venirci a sentire la messa e poi oggi è tutta addobbata.
Gli chiedo perché si bruci il pallone solo per la festa, risponde che San Clemente è un martire, ucciso, precisa lui, da uomini cattivi, senza però chiarirmi perché lo abbiano ammazzato.
Mi guardo attorno, vedo che Angela è entrata con la mamma e la zia.
Se ne sta tutta impettita, seria, insisto sperando in uno sguardo, anche di sfuggita, ma non giunge, o almeno io non me ne accorgo.
Intanto sono arrivati anche tutti i miei amici, Giorgio, Giuliano, gli altri, non c’è Roberto, lui è un chierichetto, in chiesa è un protagonista sulla scena, non uno spettatore come me.
Con uno strappo più forte del solito alla corda della campanella sopra la porta della sacrestia, il Sacrista annuncia l’inizio della cerimonia.
Tutti guardano da quella parte, sulla porta appare una piccola processione guidata da Don Giuseppe, seguito da ben quattro chierichetti; è proprio una celebrazione solenne, mi vien da pensare, visto che di norma i chierichetti sono uno o due.
Roberto ha in mano il gran librone delle letture, Marcello una lunga pertica con la cima avvolta in una garza bianca.
Si dispongono sull’altare, mentre il sacrista, da vero cerimoniere, si apposta vicino al pilastro che delimita l’altare. Don Giuseppe, dopo aver pronunciato alcune preghiere di rito, fa un cenno a Marcello, che gli porge la lunga pertica, il Secrista, lui non ha bisogno di cenni, si avvicina con una candela che gli è apparsa come per magia in mano, l’avvicina alla garza che prende fuoco.
Il momento è solenne, non si sente volare una mosca, ul Pretin piccolo com’è dove quasi alzarsi in punta di piedi per accostare la fiamma al globo, che prende fuoco subito, ma brucia lentamente, mentre centinaia di occhi guardano lo spettacolo.
Sospinti dall’aria calda volano in alto dal pallone pezzi di lana nera carbonizzata, che si vanno a posare qua e là, davanti all’altare, tra le teste dei bambini dei primi banchi. Non c’è stato rumore, nessuno ha proferito parola, quasi tutti hanno trattenuto il fiato e il pallone brucia fin quando non rimane che uno scheletro di filo di ferro annerito dal fuoco. I fedeli come mio padre, che seguono la cerimonia dalla sacrestia, si sono accalcati sulla porta per seguire lo spettacolo e una volta finito si ritirano ai loro posti, dove possono tornare a chiacchierare.
La messa è molto più lunga del solito.
I momenti salienti sono preceduti e poi accompagnati da canti. A intonarli è la flebile voce di Don Giuseppe, subito ripresa dalle acute voci di alcune donne, che, con il velo in testa e il volto quasi rapito da chissà quale visione, fanno gara a chi raggiunge la nota più alta sbirciandosi l’un l’altra.
Molti dei presenti, tra cui mio zio, sono come rapiti dalla mistica atmosfera.
Le appassionate melodie si alzano potenti nel mezzo della navata, sembrano salire fino alle capriate del tetto, un po’ tutti sono commossi.
La cerimonia finisce con la benedizione in forma solenne che Don Giuseppe impartisce con la tiara che dicono contenere le reliquie di San Clemente.
Assolti i doveri della messa, tutta la gente si riversa in piazza.
I soliti si avviano all’osteria per il bicchiere di vino, altri fanno capannello chiacchierando, altri ancora si sono avviati al locale dove è stata allestita la pesca per essere i primi a giocare. Lo zio e mio padre si trovano sulla piazza, si mettono a chiacchierare, scordandosi di me, che, con gli amici, vado al locale della pesca per assistere alle prime giocate. Dopo poco però, in attesa dell’ora di pranzo, ci mettiamo a giocare nel cortile e sulla piazza rincorrendoci, facendo i soliti giochi, il consueto schiamazzo.
Per il pranzo si è dovuto aggiungere al nostro tavolo un altro preso in prestito dalla sciura Lisa.
Oltre gli zii, che hanno portato anche Mario, l’ultimo nato, la mamma ha invitato mia sorella Rosella con il marito; con molta probabilità si tratta di un invito interessato, mia sorella aiuta a gestire il pranzo.
Come sempre in quelle occasioni, intorno al tavolo parlano tutti e tutti assieme, la casa si riempie di un vociare diffuso.
Intorno alla lunga tavolata con tutto quel ciarlare, le voci si mescolano, s’intrecciano, rimbalzano da un punto all’altro. Dalle tante bocche occupate a masticare i suoni escono quasi con fatica, un po’ distorti, i volti vanno via via arrossandosi, allargandosi in ampi sorrisi man mano che il pranzo procede e che i bicchieri di vino vengono svuotati.
Si diffonde in tutti l’euforia della festa, qualcosa di leggero che aleggia sopra la tavolata imbandita, su ogni commensale. Le chiacchiere, le discussioni, gli argomenti che emergono, anche se trattano problemi, preoccupazioni quotidiane e le incognite legate al futuro, sembrano essere meno infauste del solito.
Nel pomeriggio, dopo la cerimonia della Dottrina che costringe per quasi un’ora tutti in chiesa, sono stati organizzati giochi che variano di anno in anno, in funzione della fantasia dei volontari che organizzano la festa.
Quest’anno ci sono ben tre diverse competizioni cui i giovani, e anche qualcuno meno giovane, si sono iscritti.
Per la corsa dei sacchi si sono presentati ai blocchi di partenza in molti, dopotutto in paese non mancano né i giovani né i sacchi; inoltre il premio è corposo, un grosso grasso tacchino che fa mostra di sé in una gabbia posta subito dopo il traguardo.
La partenza, essendo così in tanti, si rivela disastrosa per molti, che si urtano, inciampano, perdono l’equilibrio, in alcuni casi rotolano miseramente a terra. I cinque o sei che invece si sono lanciati liberi e sicuri si contendono il traguardo sorretti da grida e incitamenti da parte della gente che si assiepa attorno al percorso. Vince uno dei tanti fratelli Brambilla, il maggiore. Ritira il premio, tolto l’ignaro pennuto nero dalla gabbia, lo innalza al cielo provocando un gran clamore tra la folla.
La corsa in coppia con le gambe legate ha una lunga e snervante fase di preparazione, non si riesce a formare le coppie.
Ci sono discussioni, trattative a non finire, ognuno dei partecipanti tende a volersi accoppiare con chi ritiene agile, veloce, che gli può permettere di vincere. Assisto ai preparativi pensando che negli anni successivi potrò partecipare anch’io a quel gioco, magari legato a Roberto, ora posso solo guardare, siamo ancora troppo piccoli.
Finalmente si presentano sulla linea di partenza cinque coppie, che hanno saldamente legato la gamba destra di uno a quella di sinistra dell’altro.
Per correre meglio i concorrenti si tengono le rispettive braccia sulle spalle, uniti a formare un solo corpo; occorre una grande coordinazione nei movimenti, bisogna portare avanti insieme le gambe legate e quelle libere, altrimenti ci s’intralcia, ci si sbilancia, si cade. È una gara avvincente, fin quasi sotto il traguardo almeno tre coppie sono appaiate e prevale di un soffio la coppia che negli ultimi metri non si è disunita, la più affiatata, capace di sincronizzare meglio i movimenti fino alla fine della corsa.
Tra gli applausi, ritira il premio, che consiste in un bel salame e una maglietta a testa con una scritta pubblicitaria sul petto.
Finite le corse ci spostiamo tutti in Curt dei Paisan Neuf, in fianco alla chiesa, dove è stato allestito il gioco delle pignatte.
Le grandi padelle di coccio, marrone scuro, si stagliano contro il cielo grigio, prossimo al crepuscolo. Sono sorrette da corde legate al palo, penzolano distanziate di un metro l’una dall’altra. Il ragionier Giulio, riconosciuto, stimato, autorevole capo dell’organizzazione dell’intera festa, si avvicina con un grosso bastone in mano, alzando il braccio misura la distanza tra le pignatte, messe ad altezze diverse per aumentare la difficoltà del gioco. Appoggiato il bastone alla più alta, costatato che ci arriva pure lui, piccoletto com’è, fa segno che può iniziare lo spasso. Nel frattempo si è formata una fila di giovani, che si spingono, si tirano per conquistare un posto più avanti, per essere i primi della fila, i primi a spaccar pignatte.
Ciò nondimeno, il ragionier Giulio è un democratico di lungo corso, va a prendere il vaso in cui ha inserito i nomi degli iscritti e, con quello in mano e il bastone vicino a mo’ di monito, si appresta a iniziare.
Si guarda in giro, visto un bimbetto in braccio al papà, gli chiede di avvicinarsi e di estrarre un biglietto. La gente assiepata segue i preamboli con attenzione e commenta l’indubbia capacità organizzativa del ragioniere. C’è perfino chi dice che di sicuro si è meritato il suo voto alle prossime elezioni.
- Aldo - urla il ragionier Giulio dopo aver letto il biglietto estratto, agitandolo in alto per mostrarlo a tutti.
Tutti si girano verso la coda, in cerca di Aldo, il sorteggiato, che, essendo mingherlino, è finito relegato quasi alla fine della fila.
Incredulo, tutto soddisfatto Aldo avanza tra la folla, spintonato dagli altri concorrenti in fila, rimbrottato dai delusi dal risultato, che gli urlano:
- Che culo! Aldo, che culo!
Lui, girando il capo in qua e in là, si gode il momento di gloria, presentandosi sorridente al ragionier Giulio.
Costui, preso un gran fazzoletto azzurro, che qualcuno nota essere del colore del suo partito, lo lega ben bene con un vistoso nodo sulla nuca di Aldo. Poi, spostandosi di fronte agita la mano per controllare, con soverchia pignoleria, che gli occhi del concorrente siano ben coperti. Dopo avergli dato in mano il lungo nodoso bastone, lo accompagna di fronte alle pignatte, gli fa fare due o tre giri su se stesso per disorientarlo e subito si allontana dicendogli a gran voce.
- Vai!
Aldo per un momento sta fermo, muovendo la testa qua e là come a cercare dove dirigersi, poi, alzato il bastone, comincia a menar fendenti in aria cercando di colpire le pignatte.
La gente, standosene abbastanza lontana per non rischiare una randellata in testa, si mette a incitarlo:
- Di qui! Di là!… A destra!… A sinistra!
Lui, forse seguendo qualcuno di quei consigli, va avanti a tagliar aria, fino a quando il ragionier Giulio gli grida:
- Alt!
Aldo ha finito il tempo a sua disposizione e non ha combinato nulla, ora tocca a un altro. Cambia la mano del pubblico che estrae il nome, ma la preparazione è la stessa, pedante, meticolosa, l’estratto è Umberto. Dopo il - Vai! - del ragionier Giulio, Umberto non si mette a menar fendenti come tutti si aspettano, muove il bastone in alto cercando una pignatta da spaccare.
Questa modalità è giudicata dal ragionier Giulio alquanto furbesca e non ammessa dal regolamento, che probabilmente ha scritto lui, e provoca un suo urlo, stando ben attento a non avvicinarsi più di tanto.
- Alt! Umberto, non puoi, non è permesso fare così, devi solo dare botte, non cercare prima la pignatta.
Di malavoglia Umberto si mette a picchiare l’aria e, proprio dopo qualche colpo a vuoto, uno centra una pignatta, che va in frantumi e gli rovescia in testa ghiaia mischiata a trucioli e segatura, sicuro regalo di Ambrusin, il falegname del paese.
Il gioco, molto apprezzato dalla gente, va avanti per un bel po’, scoprendo che le pignatte contengono noci e nocciole che si spargono per terra, raccolte dai bambini presenti, sale grosso misto a sabbia, finalmente nella quarta qualcosa di buono, un po’ di monetine mischiate a carta di giornale, e, nella penultima, un grande biglietto con scritto - Oca, visibile nella gabbia che aveva ospitato anche il tacchino della corsa con i sacchi.
Con gran disappunto di Pietro, che si è dato un gran daffare a menar fendenti, quando finalmente colpisce la pignatta ha la sorpresa di ricevere uno scroscio d’acqua in testa.
L’albero della cuccagna è stato piantato in piazza il giorno prima, a ridosso delle scale d’entrata della chiesa.
È alto cinque o sei metri, per piantarlo si è fatto un buco spostando provvisoriamente qualche sasso del ciottolato, inoltre, per assicurare la stabilità, dalla cima partono quattro robuste corde fissate ai muri circostanti. Il palo è stato cosparso con scrupolo di grasso scuro, che rende pressoché impossibile la scalata a un singolo concorrente, perciò si sono già formate delle squadre per affrontare l’impervia salita. I concorrenti si aggirano nervosi, tutti hanno indossato delle vecchie tute, legato stracci sulla testa, intorno al collo, per preservarsi dal grasso e dai piedi del compagno.
Il ragionier Giulio, con la stessa professionalità dimostrata pocanzi, procede al sorteggio dei gruppi che si agitano nei dintorni.
Poi, rivolgendosi alla gente appostata in cerchio intorno all’albero, fa segno alla prima squadra di tentare la salita.
Con consumata tecnica e probabili lunghe sedute di allenamento, il più grosso e robusto del gruppo si avvicina al palo, si avvinghia come se abbracciasse con ardore una bella ragazza e si ferma in attesa. Subito, da dietro, un compagno più minuto, aggrappandosi alla sua tuta, sale con agilità sulle sue spalle e anche lui abbraccia il palo con lo stesso ardore dell’amico di sotto.
La gente assiste con entusiasmo, i gruppi organizzati dei tifosi urlano incitamenti.
Parte il terzo, meno grosso, più piccolo del secondo, affronta la scalata provocando qualche movimento brusco dei primi due, che scivolavano per il grasso spalmato sul palo. Ha molte difficoltà, le mani non riescono a tenersi al palo, scivolano e lui non riesce a issarsi. Allora si mette a togliere il grasso con il cavo delle mani e lo scrolla con un gesto veloce verso il basso, provocando il fuggi fuggi della gente sottostante, per evitare di prendersi gli schizzi, e il severo rimbrotto del ragionier Giulio, che minaccia a gran voce, superando anche le grida di riprovazione degli astanti, una secca squalifica.
Il putiferio dove aver provocato sconforto nel concorrente, che non sa più cosa fare.
Il gesto istintivo gli ha attirato l’ira della folla, che si è vista piovere addosso schizzi di scuro, puzzolente grasso. Decide di rinunciare, tra i rimproveri degli amici e i lazzi della gente. Sceso, con i compagni che lo sgridano, si va a sedere sui gradini della chiesa in attesa di un nuovo tentativo, sperando che gli altri gruppi non riescano a raggiungere i salami, i prosciutti, le altre leccornie che stanno dondolando in cima al palo.
Si presenta un’altra squadra, che, a detta delle voci che girano tra la gente, è la favorita, anche perché è il gruppo che ha vinto l’anno prima, e ha già vinto la cuccagna in altri paesi della Brianza.
Si vede che sono in gamba, anche il terzo si posiziona in attesa dell’ultimo, il mingherlino del gruppo, incaricato di arrivare alla meta. Con fatica riesce a salire, con la punta delle dita arriva a toccare un salame, cerca di afferrarlo, dopo qualche tentativo deve desistere, sotto si abbassano e il salame si allontana dalle sue dita. Parte della gente è delusa, lo spettacolo è diventato avvincente, il primo gruppo semi-squalificato riprende la speranza di poter ancora provare.
Il terzo gruppo non si dimostra all’altezza, infatti desiste quasi subito.
A quel punto tocca a un gruppo di ragazzi che viene da fuori paese, sono di Cortenuova.
Il regolamento non proibisce formazioni straniere, sono giovanotti conosciuti, Cortenuova è solo a qualche chilometro, sono amici, compagni di lavoro, ma, in quel giorno, in quel gioco, sono nemici e in quanto tali si stanno sorbendo gli astiosi sguardi e le riprovazioni pronunciate a denti stretti e a bassa voce dagli spettatori.
La gente non osa, forse per scaramanzia, gridare apertamente la sua avversione, ha paura che loro possano vincere.
Quel gruppo va molto vicino a vincere, il quarto ragazzo della squadra con le mani protese, accompagnato dalle acute grida delle donne che cercano di scongiurare l’evento, cerca di afferrare la mortadella che gli dondola sopra la testa. Con una sola mano non riesce ad afferrarla, da sotto è troppo grossa, troppo tonda. Allora, poggiando il piede sulla capoccia del compagno di sotto si alza quel tanto che gli serve ad afferrare la fune. Il gesto è accompagnato dalle grida di tutta la gente, che ha capito la mossa e teme che ce la faccia:
- Nooooo!… Noooooo!
Lui sembra avvertire le grida di dissenso come incitamenti, al punto che riesce con le dita ad afferrare la cordicella che lega la mortadella alla ruota e, con uno strappo, a staccarla; in quel momento la piazza ammutolisce.
Ma la sua mano è impregnata di grasso.
Si vede a occhio nudo che sta stringendo con forza le dita, s’intuisce che la bologna gli sta scivolando dalla mano.
Centinaia di occhi sono fissi su quella mano, su quella corda e sulla panciuta mortadella, nessuno urla più, hanno tutti la bocca aperta, il fiato sospeso, seguono ammutoliti il volo che la bologna fa prima di spiaccicarsi sull’acciottolato della piazza proprio davanti al ragionier Giulio, che non nasconde un ghigno di soddisfazione, che al contempo si palesa con un grande boato di giubilo del popolo. Il paese ha evitato l’onta.
 Racconti
Racconti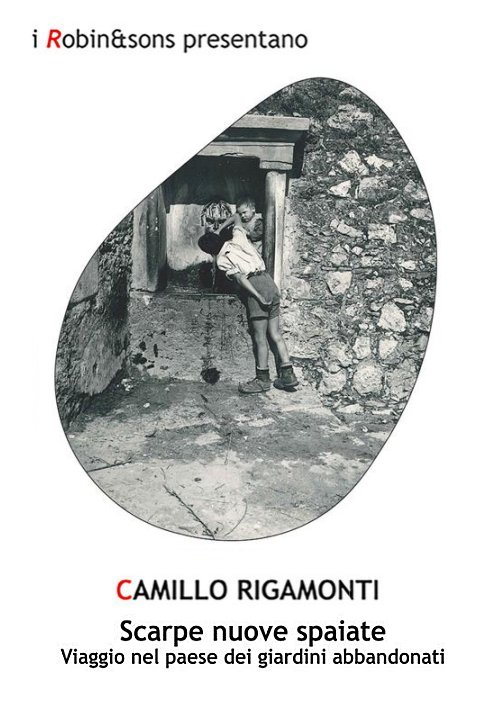 Scarpe nuove spaiate
Scarpe nuove spaiate Quattro sfigati e una Seicento
Quattro sfigati e una Seicento Casa Aragosta
Casa Aragosta Margherite
Margherite